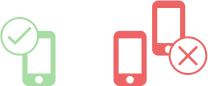Commetteremmo un gravissimo errore se pensassimo di assistere, tra israeliani e palestinesi, soltanto ad un tragico Amarcord di altre guerre, di altro sangue, di altre provocazioni. Il conflitto, è vero, dura da oltre settant’anni, e produce esplosioni saltuarie come se la Storia, ogni tanto, provasse il bisogno di sfogarsi. Ma questa volta il pericolo di una vera guerra mediorientale è maggiore. Questa volta lanci di razzi, bombardamenti, uccisioni di civili, contengono atroci messaggi che cadono in un vuoto politico internazionale (qual è la strategia di Biden? ) e contemporaneamente fanno capo a contese sempre più aspre sui fronti interni dei quattro protagonisti: Israele, l’Autorità palestinese, Hamas e l’Iran.
Netanyahu è un premier senza maggioranza dopo l’ennesimo responso elettorale di marzo. Certo, la sicurezza è una priorità che ricompatta sempre gli israeliani, e infatti i contatti per la formazione di un nuovo e diverso governo sono stati sospesi. Ma a nessuno sfugge che Netanyahu è indebolito, e che la fermezza militare può forse aiutarlo a risalire la china. Sempre che non si estendano ulteriormente le violenze tra ebrei israeliani e arabi israeliani, come è accaduto ieri da Tiberiade a Haifa, perché allora sarebbe una convivenza della quale Israele ha bisogno a essere messa pericolosamente in discussione.
Mahmoud Abbas è il capo poco legittimo dei palestinesi della West Bank. Il suo declino politico dura ormai da alcuni anni, e si è confermato di recente nel rinvio di elezioni troppo rischiose per la sua già zoppicante leadership. I disordini di Gerusalemme Est, per lui, sono una specie di ultima spiaggia: tutti devono vedere che i palestinesi non hanno abbandonato la loro causa, non sono diventati irrilevanti, ed è questo il segnale forte che deve giungere al nuovo presidente degli Stati Uniti sin qui impegnato a guardare altrove.
Hamas, l’organizzazione palestinese fondamentalista che comanda con pugno di ferro nella Striscia di Gaza, ha lanciato per prima i suoi razzi su obbiettivi civili israeliani quando sembrava che lo scontro fosse sì durissimo ma limitato alla Spianata delle Moschee di Gerusalemme. Può darsi che il significato religioso oltre che politico di quegli incidenti abbia indotto Hamas e la Jihad a non voler apparire emarginate, o indifferenti. Ma esiste anche una diversa interpretazione che si va facendo sempre più credibile, e che riguarda la vigilia elettorale in Iran mentre a Vienna si tratta per resuscitare l’accordo anti-nucleare del 2015. Questo negoziato non potrà andar lontano (lo si vorrebbe concludere positivamente entro la fine di maggio) se nel frattempo Hamas, fortemente legato ai conservatori iraniani, starà continuando a bombardare le città israeliane o lo avrà appena fatto. Basterebbe un aggravamento ulteriore della situazione per impedire alla Casa Bianca di rilanciare il patto con Teheran. E i conservatori, Guardie della Rivoluzione in testa, avrebbero la via spianata alle elezioni del 18 giugno.
L’Iran, appunto. Impegnato in una guerra strisciante con Israele, amico e fornitore di Hamas, dove tra i candidati alla presidenza rispunta Ahmadinejad e la guida suprema Khamenei dichiara dopo i fatti di Gerusalemme che Israele non è uno Stato ma soltanto una «guarnigione di terroristi» che va «combattuta».
La partita, lo si vede, si sta già allargando come i tentacoli di una piovra, e minaccia di appiccare all’intero Medio Oriente e al Golfo Persico un incendio incontrollabile. Tanto più che il punto di riferimento di tutti, l’America di Biden, attraversa una transizione strategica che nella regione è particolarmente sentita. Donald Trump aveva riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele e vi aveva trasferito la sua ambasciata, aveva sepolto la teoria negoziale dei due Stati, aveva patrocinato gli Accordi di Abramo (di Israele con Emirati Arabi, Marocco, Bahrein e Sudan) che implicitamente mandavano in archivio la questione palestinese, aveva tagliato a Ramallah i fondi di assistenza aggravando in alcuni casi autentiche crisi umanitarie. Joe Biden questi fondi li ha subito ripristinati, non riporterà l’ambasciata a Tel Aviv, vuole mantenere un saldissimo legame di alleanza con Israele, ma la sua politica mediorientale, al di là delle dichiarazioni generiche, è ancora tutta da definire. Perché nella sua visione internazionale sono prioritarie la Cina e la Russia, è prioritario un accordo anche parziale con l’Iran, e adesso si capisce fino a che punto il nuovo presidente Usa sia stato preso in contropiede dagli eventi di questi giorni. Le trombe della guerra suonano ormai nello Studio Ovale. Ed è soprattutto da lì che ora devono arrivare segnali chiari, mentre non esistono formule nuove per giungere alla pace, mentre nella regione crescono le fazioni più violente e radicali, mentre è in gioco, in Israele, anche la pace interna e la compattezza sociale. Biden, come è capitato a tutti i suoi predecessori, dovrà prendere i suoi rischi e disegnare una strategia che non avrà garanzie di successo.
Ma se ciò non accadesse, e non accadesse a tambur battente, il rischio sarebbe ancora più grande: quello di consentire che una tragedia senza fine si approfondisca e si allarghi. A due passi da casa nostra e dalla già tormentata area mediterranea.
13 maggio 2021, 22:43 - modifica il 14 maggio 2021 | 09:38
© RIPRODUZIONE RISERVATA